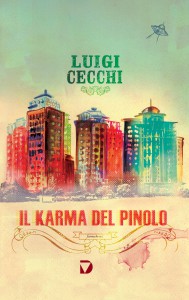Lo sapete quali sono i taxi sicuri a Roma? Nel traffico caotico del racconto on the road dell’esordiente Luigi Cecchi “Nascita di un edificio” (tratto dalla raccolta “Il karma del pinolo” in uscita per i tipi Del Vecchio, che ringraziamo per l’anticipazione), il traffico la fa però da padrone e servono un bel po’ di imprecazioni per esorcizzarlo. Prima di licenziarvelo vi facciamo un po’ chiarezza sul mezzo bianco e a tassametro.
A qualcuno sono capitate cose non belle coi taxi (abusivi e non) e allora, per farvi cosa gradita, ecco le regole che il Comune, nella sua ufficialità evidenzia come “sicure”:
“Volete muovervi in fretta in città e non volete usufruire del servizio pubblico? Rivolgetevi ad una compagnia di taxi. Il numero unico per chiamare un taxi è 060609.
Per l’elenco delle 65 postazioni attive su tutto il territorio di Roma e per altre utilità sul servizio taxi, consultare www.060608.it.
Per informazioni sul tariffario completo vai a www.comune.roma.it.
Le vetture adibite al servizio taxi del Comune di Roma sono di colore bianco ed hanno sul tetto la scritta “TAXI”. Sugli sportelli anteriori sono applicati il simbolo del Comune di Roma e la licenza, che si trova anche all’interno della vettura sullo sportello posteriore sinistro. Altri veicoli che offrono il servizio di trasporto potrebbero essere condotti da persone non autorizzate e la tariffa potrebbe, dunque, risultare superiore”. (da www.turismoroma.it)
E adesso, il racconto.
Nascita di un edificio
di Luigi Cecchi
Le strade erano affollate, come se qualcuno avesse indetto
un Carnevale all’improvviso. La marea delle famiglie solitamente
inchiodate nelle case dal ripetersi della quotidianità,
aveva deciso di riversarsi nelle strade, per riprendersi
quel poco di incoscienza che spetta un po’ a tutti.
I meno impreparati avevano sollevato grossi cartelli sui
quali erano stati fatti scivolare i colori sintetici di bombolette
spray, segnando su legno, cartone o lenzuola di stoffa
l’approvazione per quanto stava per accadere.
Un fatto straordinario, che aveva meritato l’apertura di
tutti i notiziari sin dal giorno prima. Dopo decenni di architettura,
progettazione, abusivismo e costruzioni su ordinazione,
un edificio sarebbe di nuovo venuto al mondo
in modo naturale.
La stampa assediava le balconate. Braccia meccaniche di
gru noleggiate per l’occasione emergevano dalla massa in
agitazione, sollevando in alto le telecamere. Il rumore degli
elicotteri rimbombava tra le finestre sciogliendosi nei
cori esaltati dei manifestanti.
Qualcuno aveva appeso un grosso quadrato di stoffa sulla
rete di recinzione del campo di calcetto, e sopra, a colpi
di pennello, c’era scritto: meno edifici, più case!
Marco se ne stava nascosto dietro la propria cassetta degli
attrezzi, una grossa scatola di metallo laccata di rosso,
le cui cassettiere erano piene di pinze, morsetti, cacciaviti
e nastro isolante. Schiacciato nel sedile posteriore del taxi,
assisteva intimorito all’entusiasmo della gente.
Marco era un elettricista, ed era stato chiamato d’urgenza
sul posto. Sudava, faceva caldo; il taxi procedeva lentamente
e il sole picchiava sulle lamiere della vettura infuocandole.
I capelli biondicci gli si erano appiccicati alla
fronte, gli occhiali si erano appannati e non sapeva bene
come si fossero sporcati. Ma non osava aprire il finestrino.
Teneva la cassetta degli attrezzi sulle ginocchia, abbracciandola
come se si trattasse di un salvagente lanciato a un
naufrago in alto mare. Deglutendo si ripeteva di aver fatto
proprio male a lasciare il numero di telefono a Pietro, l’assessore
all’urbanistica. Che poi da qualche mese era suo genero,
quindi non è che avesse avuto molta scelta.
– Toglietevi di mezzo, teste di cazzo! – gridava il tassista,
un omaccione dalla pelle scura, forse di origini indiane,
che imprecava in dialetto meglio di come Marco aveva sentito
fare al più radicato dei suoi amici romani. Aveva detto
di chiamarsi Karim, o almeno questo era quello che Marco
aveva capito.
– E’ tutto bloccato, non arriveremo mai… Vuole scendere
e farsela a piedi? – gli domandò, voltandosi indietro.
– Santo cielo, no! – rispose Marco, stringendo ancora di
più la vecchia cassetta degli attrezzi. Scendere dalla macchina?
Come gettare una bottiglia nell’oceano. Sarebbe stato
risucchiato dalla risacca e trascinato in alto mare… poi
sospinto dalle gomitate sarebbe stato abbandonato da qualche parte,
dovunque la folla avesse deciso di sputarlo via,
su un marciapiede a caso.
Ora, orde di manifestanti si accalcavano contro le portiere
ballando e gridando. La città era impazzita.
– C’è un posto di blocco, forse facciamo prima del previsto…
– lo tranquillizzò il tassista. – Se la stanno aspettando,
ci lasceremo dietro tutta questa gente.
Marco si sporse con la testa tra i due sedili anteriori. Vide
l’edificio.
Era proprio quello, sì. Un palazzo di fine Ottocento, color
ocra, con stuccature annerite, balconcini in pietra e bassorilievi
rosi dal tempo. Emergeva oltre le migliaia di teste,
più in alto delle reti di recinzione, e si stagliava minuscolo
con i suoi tre piani di fronte alla sede della società delle telecomunicazioni,
che gli torreggiava alle spalle. Un colosso
scolpito nel vetro e nell’acciaio, che lo soverchiava con la
tracotanza di una sentinella cyborg. E anche le costruzioni
alla sua destra e alla sua sinistra non erano meno imponenti.
La sede di una banca, lucida e flessuosa, e un centro
commerciale con multiplex diciotto sale, le cui insegne illuminate
al neon non cessavano mai di sparare salve di luci
sintetiche nell’aria. Gli elicotteri volteggiavano sulla zona
come avvoltoi, cercando di non darsi fastidio a vicenda.
Quando il taxi si avvicinò alla rete, alcuni agenti si avvicinarono
chiedendo di abbassare il finestrino.
– Devo raggiungere l’edificio, ho qui il signor Galimberti…
– cercò di spiegare il tassista.
– Chi? – chiese l’agente, strizzando gli occhi per dare
un’occhiata all’interno della vettura.
Il bagliore di un fuoco d’artificio gli illuminò la pelata per
un attimo. Marco allungò un documento al poliziotto, che
gli prestò poca attenzione e glielo restituì quasi subito.
– Devo vedere l’assessore, mi ha mandato a chiamare lui,
credo che sia urgente, – spiegò l’elettricista, rinfilando la
carta d’identità in una tasca del giacchetto.
– Be’, allora potete passare, ma proseguite a passo d’uomo,
la strada non è sicura finché quel cumulo di mattoni
non ha partorito. L’assessore è laggiù, dove vedete quelle
bandiere. – Poi l’agente si chinò a guardare negli occhi l’elettricista.
– Lei sa come si fa a farlo nascere, vero?
– No, – rispose Marco.
Poi uno scoppio fece voltare tutti in direzione del centro
commerciale e la folla iniziò a gridare. Le urla si sommarono
insieme in un crescendo, mentre centinaia di gambe
indietreggiavano impaurite. Un pezzo di cornicione del palazzo
ottocentesco si era staccato crollando su un furgone
della polizia. Il colpo aveva fatto esplodere la vetrata del
McDonald’s lì vicino, che per fortuna era stato sgombrato.
Appena il primo spavento si attenuò, un rumore di cavi
metallici fece vibrare l’aria, seguito da un sinistro scricchiolio
che sembrò percorrere l’asfalto fin sotto le gomme
del taxi.
– Dobbiamo sbrigarci, – sollecitò Marco, – credo che
siano le prime contrazioni.
Karim annuì vigorosamente con la testa, poi guidò il taxi
oltre il varco nelle reti che delimitavano l’area pericolosa.
Gli agenti fecero giusto in tempo a richiudere i cancelli,
che una ragazza si lanciò su uno dei sostegni metallici,
sollevando in alto una sciarpa e urlando a squarciagola degli
slogan femministi. Un manipolo di poliziotti corse a
farla scendere. Marco torse la testa fino alla spalla pur di
seguire la vicenda, ma poi fu distratto da un altro rumore,
che superò in fragore le urla della ragazza.
Le finestre del secondo piano del palazzo si infransero
all’unisono, spruzzando fuori una nuvola di schegge di
vetro che ricaddero in strada tintinnando come monetine.
Subito dopo, la testa di marmo di un fauno si staccò dalla
volta sul portone del palazzo, precipitando sui gradini
bianchi del porticato, e poi rotolando giù fino all’asfalto.
Karim proseguì senza fermarsi. Svoltò a sinistra e imboccò
un viale illuminato da lampioni d’emergenza. La macchina
passò di fronte a un’equipe intenta a misurare il dilatamento
del terreno, a un centinaio di metri dal palazzo
in pieno travaglio.
Una squadra di vigili del fuoco tagliò la strada al taxi, precipitandosi
a puntellare di nuovo le pareti del primo piano.
– Ecco l’assessore! – esclamò Marco, puntando il dito
verso il genero. – Scendo qui. Grazie mille.
Si frugò nelle tasche e allungò una banconota a Karim,
poi si affrettò goffamente verso Pietro, che era indaffarato
a discutere con gli addetti del proprio ufficio stampa. Vedendolo
arrivare, l’assessore si congedò dagli altri e si mosse
verso di lui.
– Cazzo, ma quanto ci hai messo? Qui sta succedendo
un casino! Ti avevo detto di sbrigarti!
– Non è che… La strada… – bofonchiò Marco, mentre
Pietro lo stringeva in un vigoroso quanto breve abbraccio.
Gli occhiali gli calarono fino alla punta del naso, si affrettò
a rimetterli al loro posto.
– Va bene, va bene. Ascolta, quell’edificio del cazzo sta
per partorire, e qui abbiamo la stampa nazionale che vuole
riprendere l’evento in diretta. Lo sai che significa? Che
se il parto non va a buon fine, faccio la più grossa figura di
merda della mia vita. Ecco perché quello stronzo del sindaco
non è qui. Hai capito? Non vuole rischiarsela. Invece
io qui ci devo stare, a rischiare il mio culo, e anche quello
della mia famiglia. Che adesso è anche la tua, no? Quindi
tu quel palazzo me lo devi far nascere, e deve essere bello
come la mamma, cazzo!
Marco continuava ad annuire con aria persa. Alcune persone
dell’ufficio stampa di Pietro lo andarono a recuperare.
Pietro si distanziò da Marco quanto bastava, poi si aggiustò
la giacca e il riporto grossolano. – Oh, mi fido di te eh…
mi raccomando! – disse, e si eclissò, scortato da uomini con
occhiali scuri e camicia bianca, come si confà ai vip.
Marco invece rimase da solo, in silenzio, in mezzo al prato.
Come si confà a chi lo prende in culo. Decise di non
pensare troppo alla responsabilità che aveva nei confronti
di Pietro, e di sua figlia Carolina. Si concentrò su quello
che era il suo lavoro, venticinque anni di esperienza. Notò
la centralina elettrica del quartiere, all’angolo della strada.
Il casotto di cemento sparava in aria scintille come fosse
Capodanno, tanto che persino i vigili del fuoco lasciati a
presidiare l’area si tenevano a debita distanza.
Con passo lesto scese verso la torretta. Convinse i vigili
che era un tecnico mostrando loro un cercafase e delle
pinze, poi chiese di portargli al più presto cavi ad alta conduttanza.
La situazione era chiara: l’edificio aveva bisogno di più
elettricità, stava per soffocare, e prima ancora di lui sarebbe
morto il nascituro. Marco si mise subito al lavoro.
In meno di un’ora i vigili del fuoco recuperarono qualche
centinaio di metri di cavi elettrici supplementari, e lo
aiutarono a togliere e a ripristinare la corrente ogni volta
che c’era bisogno di intervenire.
L’edificio ottocentesco sussultava con vigore ogni volta
che l’energia elettrica veniva sospesa, e le scosse causarono
la perdita di molti dei mosaici che impreziosivano le volte
del chiostro interno. Fu una corsa contro il tempo, poteva
cedere da un momento all’altro. Ma non lo fece.
Quando Marco finì di lavorare alla centralina, il sole era
già calato oltre il profilo della città all’orizzonte. Il palazzo
restò in silenzio ancora per qualche minuto, stretto tra gli
imponenti suoi fratelli, che impassibili assistevano alle sue
doglie. L’intera struttura sembrò sollevarsi su se stessa, distendendo
i colonnati e facendo scricchiolare ogni infisso.
Le tegole del tetto vibrarono come percorse da brividi di
freddo. La massa di spettatori che aveva circondato la zona
trattenne il fiato, intuendo che il momento era giunto.
Dapprima il terreno cominciò a tremare leggermente, poi
il tremore si fece più intenso, come una scossa continua
di terremoto. Ogni cosa nel raggio di mezzo chilometro
tintinnò e risuonò agitata da quel fremito. Gli elicotteri si
accanirono su quello spettacolo, calando dal cielo famelici
di immagini.
Tutti i commentatori erano in competizione nel cercare
di descrivere il fenomeno con la maggiore enfasi possibile.
Ma non ce n’era bisogno, lo spettacolo in sé era già sufficiente
a far sgranare gli occhi a qualsiasi persona lo stesse
osservando, dal vivo o in diretta televisiva.
Marco scrutava la scena con la bocca aperta e lo sguardo
meravigliato di un bambino davanti a uno spettacolo di
magia. Era lo stesso sguardo che c’era sul volto di tutti,
perché nessuno ricordava più che potesse accadere una cosa
del genere.
I mattoni dell’edificio si torsero, scorrendo disordinatamente
uno sull’altro. Il rumore fu simile a quello di un centinaio
di gessetti che si spezzano su altrettante lavagne di
ardesia. Molti gridarono e si portarono le mani alle orecchie.
Poi il terreno si gonfiò. La rete di recinzione si ribaltò
finendo sulle teste distratte di alcuni vigili urbani.
Le transenne caddero, i blocchi di cemento che servivano
da fermi scivolarono sull’asfalto trascinandosi dietro
segnali di pericolo, cartelli di avvertimento, nastro segnaletico
e tutto quanto vi era attaccato. Nel mentre, l’asfalto
delle strade si spaccava come la crosta di cioccolato di un
dolce che sta lievitando. Spruzzi d’acqua emersero laddove
le condutture erano state tranciate, e i marciapiedi sembrarono
farsi da parte.
Nacque così, emergendo dal basso e scrollandosi di dosso
il terreno e i detriti, mentre sua madre scricchiolava per
l’ultimo tremendo sforzo, lasciando metà città al buio in
un momentaneo black–out.
Come primo vagito accese tutte le luci e aprì tutte le finestre
contemporaneamente, permettendo al vento della
sera di entrare e di percorrere gli ampi saloni vuoti al suo
interno.
Era una piccola palazzina liberty di due piani, con le mura
bianche, una deliziosa greca che accompagnava le grondaie,
e le tegole di un arancione scuro, quasi marrone.
Marco cadde a sedere sull’erba. Aveva gli occhi pieni di
lacrime. Assieme a lui, l’intera nazione gridò di gioia e pianse
di felicità.
Il palazzo ottocentesco era ancora in piedi, e il neonato
era in buona salute. Un’ondata di flash luminosi si abbatté
sull’edificio appena nato, e le braccia delle gru gli si strinsero
attorno per riprenderne gli interni. Un vigile del fuoco
si avvicinò all’elettricista, e lo aiutò a rialzarsi.
– Tutto bene? – ferito? – domandò.
– Sì… Sto bene, sono solo inciampato. Grazie, – rispose
Marco.
Il vigile si smosse col dito il pizzetto biondo, poi notò la
cassetta degli attrezzi lì sul prato.
– Lei è l’elettricista che ha lavorato alla centralina oggi
pomeriggio! – esclamò. – Ha fatto un buon lavoro. Sono
quello a cui ha mostrato il cercafase quando le ho chiesto
di identificarsi. Mi chiamo Michele, abito qui vicino.
– Oh… bene, – fece Marco, senza nascondere un certo
imbarazzo.
Il vigile indicò l’edificio ottocentesco, illuminato dai fari
d’emergenza della protezione civile. – Ci tenevo a quel
palazzo, era tutto quel che restava di un periodo migliore.
In tutti i sensi. Per fortuna ha retto il parto, sapevo che era
meno malandato di quel che sembrava da fuori.
Marco lo ascoltò in silenzio. Solo quando Michele finì
la frase, realizzò di essersi dimenticato di porgergli la mano.
Lo fece. Michele si tolse il guanto e gliela strinse vigorosamente.
– Marco Galimberti, sono… un elettricista, – disse.
Poi si chinò e raccolse la sua cassetta degli attrezzi laccata
di rosso. Rialzatosi, sentiva di dover dire qualcosa. Il
vigile era lì, immobile, che ammirava a debita distanza il
carosello che si era creato attorno al nuovo nato.
– Vedrà che con qualche restauro, tornerà migliore di
prima. – Fu tutto quello che gli uscì dalle labbra. Non era
granché, ma aveva quel mix di retorico, speranzoso e rassicurante
che va sempre bene, in quasi tutte le occasioni.
– Oh no, non credo che lo restaureranno, – rispose Michele,
senza distogliere lo sguardo dai bagliori dei flash.
– Era già stato sgombrato diversi mesi fa, prima che si accorgessero
del neonato. Anzi avrebbero già dovuto demolirlo…
Lì sorgerà un centro polifunzionale modernissimo.
Gliel’ho detto, io abito da queste parti, sono voci che girano
da tempo.
A Marco si gelò il sangue nelle vene.
– Non possono più demolirlo… ormai è un patrimonio
nazionale!… Probabilmente questo sarà stato l’evento più
seguito dopo la finale dei mondiali del 2006!
Michele infilò le mani nelle tasche del giubbotto catarifrangente,
e fece spallucce.
– Ma si figuri! Se la ricorda la cittadella olimpica di Torino
dello stesso anno?… Per un po’ resterà tutto al suo posto,
certo… Magari con qualche proroga a favore, sull’onda
dell’entusiasmo. Ma poi se lo scorderanno tutti, capirai,
tre piani di mattoni… Dal palazzo di fronte per accorgertene
devi guardare in basso! Quelli che hanno investito
i soldi non si faranno certo intenerire dai sentimenti.
Prometteranno di mettere un bel monumento davanti al
nuovo mostro di metallo, e saranno tutti contenti. Dia retta
a Michele, io mica sono nato ieri.
Si voltò e sputò per terra. Quasi per darsi un tono, ma al
contrario. Poi si allontanò, salutando con la mano. Marco
lo seguì con lo sguardo, finché non superò le transenne e
sparì tra la folla.
Poco più in là, una folla di giornalisti stava assediando
l’assessore. Era il suo grande momento, conosceva Pietro,
l’avrebbe sfruttato al massimo. Strinse tra le braccia la sua
amata cassetta degli attrezzi e sgusciò tra le maglie strappate
della rete più vicina. Si mosse fra gli spettatori commossi,
poi fra gli agenti distratti, e raggiunse senza fretta la
strada trafficata più vicina. Le persone già se ne tornavano
a casa con la faccia stanca. Marco alzò la mano, e un taxi
che passava poco distante gli si affiancò pigramente. Mentre
con un balzo incerto saliva a bordo, un solo pensiero
gli ronzava per la testa. Rosa gli aveva promesso le fettine
panate per cena. Ormai sarebbero state fredde.
Luigi Cecchi è nato nel 1977 e vive a Bracciano, in provincia di Roma. È autore delle strisce a fumetti “Drizzit” e del comic “The Author”. “Il karma del pinolo” (Del Vecchio) è il suo primo libro.