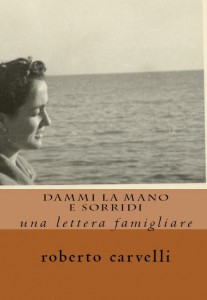Abbiamo pubblicato su wattpad (qui) per chi ha più facilità di lettura lì tutta la prima metà di “Dammi la mano e sorridi. Una lettera famigliare” che potete leggere in toto su Amazon (qui). La pubblichiamo anche qui corredata dalle foto di Pasquale Noia (che ringraziamo per avercele mandate), fotografo appassionato e lettore del nostro sito. Dal libro è stato tratto un cortometraggio in concorso ai David di Donatello.
DAMMI LA MANO E SORRIDI. UNA LETTERA FAMIGLIARE
di Roberto Carvelli
A mia madre
“Ci vogliono giorni, passano anni:/ Goethe, mio eroe/ e maestro del dire essenziale,/ anche questa volta hai colto nel segno:/ la durata ha a che fare con gli anni,/ con i decenni, con il tempo della nostra vita:/ ecco, la durata è la sensazione di vivere”.
Peter Handke, Canto alla durata
“Per quanto mi riguarda pretendo da uno scrittore, grande o mediocre che sia, un racconto semplice e sincero della sua vita e non soltanto di quanto ha sentito e capito della vita degli altri uomini; come ne scriverebbe ai suoi parenti da un paese lontano”.
Henry D. Thoreau, Walden o Vita nei boschi
§§§
Sono nato a gennaio. Quindi mani in tasca e camminare. Sono di gennaio così come si è di un partito o di una squadra. A volte di una donna o di un uomo. Appartengo al mio mese, alla sua malinconia e al gelo, al suo infaticabile partire verso i mesi che restano. Sono del Capricorno: segno lodato per la costanza e biasimato per l’andatura solitaria. Nella tradizione greco-romana è in questo spazio dello zodiaco la porta attraverso cui ci si disincarna: la porta degli dèi, passaggio per una vita spirituale.
Abituati all’abbraccio dell’inverno non soffriamo della sua stretta perché già adusi al suo rigore e ci copriamo. Sotto vestiti sobri e panni di riservatezza, come sotto la terra gelida il seme, germogliamo. Inizio di un nuovo ciclo fondato sulla perseveranza, l’industriosità, il senso del dovere, diamo il benvenuto a un anno nuovo. Nuovo non solo di agende o di pagine di calendario, numeri rossi e strappi già segnati, ma di trasformazioni, educazione della volontà, dominio dell’istinto e della sensibilità. Virtù fredde, odiate.
L’albergo, da cui vi scrivo, è a quattro stelle. Uno di quelli con la scheda magnetica che apre le camere e in cui tutto sembra pensato per stupirti, dal cioccolatino sul cuscino, alle ricercatezze dei saponi. Eppure, se scosto la tenda damascata della finestra di fronte al letto, affaccio su una corte interna cieca, da cui non arriva luce. Sono per questo costretto a rimanere con il lampadario di vetro di Murano e le applique di ottone sulla testata intarsiata del letto sempre accesi. Nel bagno, uno specchio enorme sovrasta il lavandino di marmo color salmone, e un cestino stracolmo di shampoo e altri conforti è lì, di lato. A destra, la cabina doccia doppia con le pareti di mosaico (mosaico autentico, non l’imitazione diffusa delle piastrelle) brilla di tasselli dorati, smeraldo, amaranto, blu; ma la porta di vetro ha un pomello rotto che mi rimane tra le mani. Mi avvicino al decoro con la riserva di una pecca.
Ecco a cosa serve la carta da lettere che troviamo nelle stanze d’albergo, sulle scrivanie. Non è un lusso da poco. Per quanto abbia viaggiato molto, per quanto abbia visto stanze su stanze e atteso pigro l’ora adatta per scendere nella sala ristorante, scorrendo distrattamente giornali e libri per non avere gli sguardi di riprovazione dei camerieri, adesso so che questa generosa pila di fogli con in cima l’intestazione dell’hotel – in altri soggiorni è un’unica pagina bianca dentro una cartellina con il tagliando delle consumazioni del frigo-bar o riposta dentro un raffinato scrittoio di pelle – su cui mi appresto a scrivere il bilancio di un Natale da solo, è qui per un motivo ben preciso. Sto per scrivere una confessione, un resoconto, una lettera che forse non spedirò mai. A voi, papà e mamma. O forse a me stesso.
Questa volta il mio augurio di Natale è affidato a dei fogli. Lo pronuncio da lontano, da questa stanza di albergo, quaranta metri quadri pieni di accessori e attenzioni per l’ospite. Lo scrivo nel silenzio, mentre immagino l’aria sospesa, rotta solo dall’eco degli spari di mortaretti, che hanno le ore che precedono la festa. A Roma, in questi giorni, le mattine sono deserte, sembra che nessuno vada al lavoro e si esca solo nel pomeriggio per fare i regali o la sera per ritrovarsi a giocare a carte o a tombola. Sono giorni che passano lenti, spesso l’antidoto più sicuro alla fatica dell’anno, di un’efficacia quietante di gran lunga superiore alle vacanze estive, troppo cariche di aspettative e desideri febbrili. Non è lo stesso suono vuoto che ha la vostra vita in quel quartiere di estrema periferia dove siete andati ad abitare, in cui l’assenza sembra acuirsi e rimbombare.
Mi siedo dunque al piano della piccola toletta e calcolo di quante ore potrò disporre prima di scendere nella sala ristorante in tempo per non avere quel biasimo delle livree, contenuto o esibito a seconda del rango e del carattere. Rimproveri spesso trasferiti dalle cucine al cliente, avamposto di questa raffinata guerra che è la ristorazione, ripetuti ad ambasciata, con affettazione o ghigno, dai camerieri. Dallo sfottimento alla giaculatoria cortese ma fasulla, dai soprusi personali alle adulterazioni delle portate.
Nella mia camera conto i fogli, nell’attesa della cena. Solo, alla fine di uno stupido convegno – una inutile missione giornalistica a ore di aereo e auto per scrivere di politiche amministrative replicabili a imitazione di questo continente modello – nel lusso sproporzionato di una stanza automatizzata il cui costo, cena compresa, sarà dieci volte almeno quello del compenso per l’articolo che stenderò a Roma, nell’angustia della mia casa, scrivo. Questa sera che domani è Natale e non potrò essere in famiglia. Costretto al lavoro, all’ostinato sì delle carriere, alla disponibilità pretesa e non pagata. A dare prova di una volontà che traguardi feste e famiglie, senza né tempo né modo di poter tornare lì dove si vive, tradendo l’ovvietà casalinga di una festa famigliare.
Ora so quanta carta e quanto tempo hanno sospirato questo chiarimento. Quante stanze e quante missioni lo hanno dilatato. Ora so che queste pagine in attesa su questa ribalta indecisa tra bellezza e utilità, tra intimità e rivelazione domandano segreti. Lo specchio che mi riflette – ideato per tavolozze di ombretto, cipria e rossetto – sarà di parole. Siedo e scrivo come comandato a essere me stesso in questo inchiostro. Senza trucchi, senza campiture di fondotinta. Lo specchio, lì: come se mi intimasse onestà, come se corrispondessi con la tara della mia immagine, in una strana commistione di vanità e coerenza. “Non mentire”, sembra ingiungermi questa lastra che mi riverbera. La sedia, lo scrittoio, lo specchio. Scrivo su un banco di tribunale. Il giuramento della verità è là davanti a me e ha una faccia pallida.

§§§
Sono arrivato a rallegrare il vostro destino con dieci anni di ritardo. Il ritardo si è accumulato a forza di cure di ormoni e tentativi andati a male.
Dico ‘a rallegrare’ perché se nella vita ognuno di noi nasce per compiere qualcosa, dal punto di vista della mia famiglia, questo qualcosa sarebbe l’allegria.
Sono figlio della cupezza. Non hai mai conosciuto tuo padre, papà: morendo ti lasciò poco più che infante nelle mani di una madre premurosa e di uno zio tutore irreprensibile ma povero di calore umano. Sono storie che ho saputo molto tempo dopo ma la sensazione di essere capitato in una terra di disperazione è venuta prima e ha riguardato subito me senza che avessi però la necessaria lungimiranza di intravedere nel passato funzioni premonitrici del presente. Non ne ebbi l’accortezza prima e non ero più disposto ad averla dopo, vittima di circostanze incomprensibili.
Insomma, ho capito subito che non me la sarei passata bene. La vita costa spesso un sudore salato che la fa più appetitosa o troppo saporosa ma è pur meglio che insipida. Bisogna ripeterselo spesso, questo.
Ho quarant’anni e porto dieci. Li ho messi da parte questi due lustri per farne delle esperienze che ancora non so e a stiparli nel bagagliaio della mia esistenza rischio di perdere spazio e di non poter conservare nient’altro che questo ingombrante decennio. Così per ora non ho memoria e tutto quello che mi arriva in una forma simile al ricordo è compagno di un senso d’inappagamento che spesso mi disegna infelice.
Per voi genitori in tutti i casi io ho quarantacinque anni quindi dovrei avere un lavoro fisso, possibilmente statale, una moglie e figli, fortunatamente non ha importanza se maschi o femmine.
A ragione del ritardo accumulato, con il mutare delle condizioni economiche, la ricerca del lavoro si è fatta difficile e ambire al posto fisso sembra un’idea ritardata. ‘Mobilità’ è diventata la parola guida della ricerca occupazionale, come a rinfrancare l’inutilità di un girovagare senza meta. Sposarsi o solo sognare un’unione che duri sembra un’utopia da sussidiario. Tutto è il margine di un’incertezza di processo. È più facile invocare la fine delle ideologie come un bagno di sangue riparatore delle ingiustizie della storia. Siamo dei post, non degli ex e questo rende le cose solo apparentemente più facili.
La vostra guerra è stata vera, invece, anche se non l’avete fatta davvero fucile in spalla. Piuttosto subita in un’ombra nascosta e, a pensarci adesso, meglio sarebbe stato per voi viverla che patirla così insonora.
Avete conosciuto una risonanza quotidiana: senza nemmeno l’angoscia di un parente sotto le armi e senza partigianati o sottomissioni, il secondo conflitto mondiale ha attraversato i vostri anni come i nostri ne hanno attraversato il ricordo sui libri di scuola o nell’economia delle famiglie, nei gesti del risparmio, nelle mani lente che cercavano le banconote e si fermavano titubanti prima di riemergere a stendersi sui nostri palmi per contribuire ai nostri giochi. Quell’esitazione tra le tue dita papà è il senso della guerra, del perdurare di un dolore sotto la specola dell’incertezza più che del terrore. Il volto di Michelangelo, è arrivato comunque anche tra i polpastrelli di allora e se ne è andato seminando la casa di costruzioni ma non di soldatini che erano giochi per compagni più coraggiosi, figli di genitori meno traumatizzati dall’odore della guerra, più combattivi o meno indulgenti verso la paura, loro.
Noi, io e mio fratello, abbiamo avuto per noi solo la fantasia semplificata dei trenini Lima: per risparmiare, perché la cura dei particolari dei più costosi Rivarossi o Merklin, non era per le nostre poche fortune di allora.
Prima c’era stata la raccolta delle figurine dei calciatori, un pericoloso vortice di spesa fondato sull’azzardo. Come una catena senza fine che a pochi vuoti dal completamento degli albi s’interrompeva soccombendo a un gioco di probabilità che non si aveva più soldi di aspettare. Era la legge di Pizzaballa, il portiere che lasciava incomplete molte collezioni.
Insieme alle figurine, la raccolta degli adesivi, una più umile ricerca legata all’altrui considerazione e in odore di questua. Entravamo a turno nei negozi, prediligendo quelli sportivi più pronti alle sponsorizzazioni, e ne uscivamo con quelle forme di carta adesiva tutte diversamente disegnate e colorate. Le appiccicavamo poi su quadernoni a fogli grandi come se volessimo imitare il formato degli album da edicola. Qualcuno dei nostri amici ci tappezzava persino le ante degli armadi o le testate dei letti delle camerette da ragazzi: ci rendevamo complici così di marche e loghi, ben prima che la pubblicità iniziasse la sua massiva manovra colonizzatrice.
Siamo stati dei perfetti appaltatori, io e mio fratello. Lui rosetta, io ciriola. Lui prosciutto cotto – il crudo costava troppo – io provolone. Lui l’Intrepido io Il Monello. Ci siamo divisi in sfere di influenza, senza guerre di predominio. Già da piccoli era destino che saremmo andati d’accordo pur mantenendo diversità.
Economizzare, stringere la cinghia, risparmiare: questo il glossarietto economico di quegli anni di privazioni. E, senza poter dire “siamo poveri”, abbiamo imparato a dire “non siamo tanto ricchi”. Solo poi, a scuola, le suore ci avrebbero insegnato “benestanti”, una categoria senza pericolo d’indigenza ma anche senza luccicanze, e ci avrebbero lasciato intendere che unicamente per il fatto di contribuire degnamente al sostentamento e al mantenimento loro e della loro Casa, anche io e mio fratello eravamo da considerare membri di quella organizzazione generosa verso gli altri ma modesta con se stessa.
Sembrava mancarci tutto pur avendo tutto perché tutto era frutto di una fatica che gustavamo amara e frapponeva tra noi e i nostri desideri un velo di colpevole cedimento al superfluo. Io, in questo masticare amaro, ho dimenticato il senso della soddisfazione del piacere, la passione per uno sforzo ripagato. Ho assimilato, invece, l’idea di una ineluttabile volontà superiore alla quale erano da imputare quei soddisfacimenti che scissi da noi, dal nostro instancabile lavoro per ottenerli, hanno finito per indossare l’abito del miracolo e a sostenere il peso degli ex voto che per debito di gratitudine avremmo dovuto portare appesi alle nostre braccia.
Con i trenini ci sono stati anche i francobolli. Collezione italiani usati. Bastavano un paio di forbici, una vaschetta di plastica piena d’acqua calda, bianca di pressione e di calcio per staccarli dalle buste e uno straccio di lino strappato a qualche vecchio e modesto corredo consunto su cui farli asciugare. Come pinzette andavano bene quelle per le sopracciglia della mamma che conservavano quell’aria domestica e usata che avrebbero condiviso con la colla dissolta delle affrancature e il viola dei timbri scoloritisi nell’immersione. Qualche soldo fu speso per i raccoglitori ma con un convincimento di riguardosa elasticità per quel loro essere cassaforte di un valore rigorosamente umile, merce di scambio, denaro congelato.
A ben guardare, tutta questa rinuncia al consumo ebbe una lunga mano teorica, un braccio di sostegno religioso che aveva decretato la legittimità di quel risparmio incollando e confondendo uso e abuso della vita e facendo del denaro un limite prima che una materia per l’esercizio del nostro valore. Ci avrebbe pensato l’audacia di una nuova imprenditoria politica tutta votata a un accumulo indiscriminato – portando il nostro Paese tra le grandi potenze prima e sull’orlo di un baratro economico e morale poi – a insegnarci una religiosità laica con cui avremmo accettato il commercio come radicale della nostra stessa vita.
Prima che tutto questo si compisse con una rapidità che non fece in tempo a spaventarci, c’erano state tonache parsimoniose anche nello svelare i segreti dell’universo, nel rivelarne la misteriosa perfezione. Così facendo avevano creduto di lusingare il nostro spirito di ricerca mortificando la curiosità del peccato. E per un po’ d’anni credemmo anche di peccare con un coraggio che ci faceva sembrare allegri ma che ci costrinse a modellarci addosso una religiosità meno ottusa. Molti s’inventarono divinità loro rischiando sacrifici riparatori e schiavitù peggiori. Altri si fecero dèi di se stessi o recisero ogni possibilità di legame col mondo superiore.
Adesso era la religione del commercio a mettere d’accordo tante anime. Era una culto facile. Senza divieti ma con comandamenti trasformisti che andavano bene in quel tempo d’incertezza. Si convertirono in tanti. Noi no. Era un passaggio troppo brusco per noi catechizzati al risparmio. Era una ricchezza conservativa la nostra. I sentimenti non andavano spesi, impiegati, ma tenuti per sé e nascosti a un mondo usurpatore. A dover essere protetti erano non solo i beni immobili, le nostre case in cui non entrava nessuno, ma i denari e le gioie e i dolori che non andavano dimostrati perché una volta dati in pasto agli altri erano persi e questo valeva anche tra di noi.
La lunga mano teorica era quella dei parroci della nostra parrocchia, Don Canio e Don Bruno, che cedevano il passo a un favolistico misticismo senza più rispecchiamenti reali. Iniziarono con lo svuotarsi i corridoi attigui alla sala – antichi indici della maggiore presenza – da cui si assisteva alla funzione partecipando solo con l’ascolto dei ripetitori e rimproverandosi del ritardo.
Col tempo molti ragazzi scelsero di andarsene a passeggiare o a giocare a pallavolo nel cortile dell’oratorio e nessuno aveva più voglia d’intonare fratello sole sorella luna, o resta con noi non ci lasciar. Le chitarre suonavano a vuoto e noi assistevamo a quel loro progressivo attutirsi e poi nascondersi dietro adesivi che le facevano strumenti-giocattolo parcheggiati in qualche angolo dell’oratorio convinte ad assistere a qualche più emozionante danza col pallone. Si giocava su delle piastrelle di cemento grigio, quadrellate. Tutt’intorno aiuole di soli cipressi che davano al luogo un’aria cimiteriale. L’allegria dei fiori era stata relegata dalle suore in un giardino chiuso come un fondale da foto al quale si accedeva solo nei giorni delle comunioni o delle visite di qualche alto prelato.
L’unico legame che quelle gare mantenevano con l’edificio che le ospitava era una resistenza forzata alla bestemmia alla quale si cercava compensazioni linguistiche molto fantasiose.
Dentro, al vantaggio di un più agevole ingresso nella cappella centrale faceva da contraltare quel triste vuoto dei banchi e dei corridoi. Le porte attraverso le quali avevamo assistito tante volte alla funzione, senza vedere mai l’altare, ora erano state chiuse, riconsegnate ai casalinghi passaggi di suore e noi eravamo stati catapultati tra le panche semivuote, imbarazzati nel vedere allo scoperto quella nostra religiosità privativa.
Le funzioni erano più veloci con una persistenza di voci stonate in fuga solitaria sulla timidezza degli altri e non rassegnate al silenzio degli strumenti che intonavano canti di sussistenza. Tra queste anche le nostre, fedeli al precetto che le suore enunciavano non senza un’ombra di giustificazione per le inevitabili dissonanze e per le stonature. “Chi canta prega due volte”, dicevano, e noi avevamo bisogno di mettere da parte un fondo di benevolenza divina.
Alternavamo questa presenza a quella più variabile del ritorno dai fine settimana fuori Roma che ci sorprendevano all’ora limite lontani dalla nostra parrocchia. Capitavamo allora in chiese di passaggio. Più spesso a Sant’Angela Merici, strana chiesa moderna a pianta circolare e in cortina rossa in una traversa della via Nomentana in cui dominavano canti registrati come telefonati da un aldilà un po’ marziano.
Non resistemmo a lungo in quella posizione centrale della nostra parrocchia ufficiale, bersagli del riconoscimento degli altri. Iniziammo dei pellegrinaggi domenicali cercando di emigrare, non più casualmente, da quella ristrettezza per raggiungere basiliche in cui spiccava di più il vuoto dei banchi, il silenzio delle navate, le candele spente, i microfoni altisonanti che rimbalzavano la voce di qualche più colto ed arguto predicatore. Ed è solo tra quei vuoti che ci è sembrato di riconquistare l’assoluto e il libero arbitrio.
Solo tu, mamma, continuasti a preferire il grigiore delle funzioni decadenti nella cappella di quartiere alla lontananza delle cattedrali della città. Scegliesti la cerimonia serale della domenica come l’ultima occasione di chi non nutre più speranze (ma era in definitiva la traccia del perdurante ritardo e del rimando su cui si fondava il tuo carattere). A me, che qualche volta t’ho accompagnata, piace ricordare quel parlare quieto del sacerdote, voce smarrita tra i banchi vuoti ma forse anche benedicente per l’intimità di quella funzione, per quella liberalità del nostro sentire religioso non disposto verso il biasimo. Io e te da qualche parte e un senso di pace rassegnata che ci abitava. Il calore di quella disperatissima malinconia mi ha informato pensieri di grande gioia e mi ha invitato a credere che la vita non è lì dove non si vede e che anzi ciò che non è visibile non è, eccetto che nel profondo dei nostri cuori, tra i nostri desideri.
§§§
Siamo in una fase residuale. Lo siamo tutti, lo siamo insieme. Vi conosco non più genitori ma bambini, per quanto adulti. Si assottigliano le domande, cedono le preoccupazioni e si fanno strada le richieste lamentose come se fosse una pena per voi l’aver bisogno. Ci vediamo e ci salutiamo ogni volta come l’ultima. Con un calore nuovo. Un calore che non vi sapevo dentro prima di ora ma che riconosco impaurito, quasi colpevole.
Il tempo sembra indicarvi la porta. Cerimonioso vi segna un’uscita lontana ma visibile, senza affrettarvi, senza incalzarvi. Fa il contrario di quello che faceva con noi quando eravamo piccoli. Ci diceva “andate avanti e vedrete!”, ma per noi non era da obbedire né da farsi persuadere. Andavamo in un naturale precipizio di giorni. Cosa dice a voi il tempo, adesso? Forse cala l’ombra della segretezza, lo scuro di un mistero che s’infittisce? La paura alza una nebbia e si procede comandati a un “finché si può”? O forse prende un’ansia di rallentare, di decrescere, come accadde a noi due figli, per altro verso, quando volevamo essere altrove e più avanti e dunque vi odiavamo per il vostro gravare come l’ormeggio del “non ancora” – un’inaccettabile dilatazione per tutta quella fretta e quell’energia?
Siete nella vostra piccola casa in un ammutinamento verso le cose esterne. Chiusi a tutto, persino al mondo che vi porto da fuori, che vi racconto. Mi ascoltate con un’espressione che scambio ogni volta per interessata e che poi riconosco come assorta. Ma non è sul mio racconto che si concentrano i vostri pensieri. È dal vostro salto logico successivo alle mie notizie che capisco che c’era un pensiero banale, quasi sempre angoscioso, che vi ha tormentato prima e vi tormenta ancora fino allo sfiato di voce che un po’ vi acquieta. E questo lo sapevo già. Siete così da sempre: preoccupati. Che tutto vada per il verso giusto, che non rimangano debiti con nessuno, che le cose da fare siano fatte. Non c’entra l’età con la sua fretta speciale e fuori tempo. È una questione antica.
Siete nella casa, le tapparelle sempre abbassate o alzate per poche ore e a un’altezza non sufficiente a fare entrare ossigeno. Siete in una specie di camera stagna con bagni e cucina e salone. La luce la tenete a distanza come vampiri. Se non vi avessi conosciuti negli anni dovrei pensare che cercate il buio come una camera di decompressione che anticipi le conclusioni logiche del vostro viaggio. Ma è così da sempre: era così anche nella casa di me bambino a Montesacro. Un’affezione al nascondersi che non posso non pensare abbia avuto principio in quel modo tutto meridionale di vivere la propria presenza al mondo che avevi soprattutto tu, papà. Alla morte del nonno – tu avevi solo due anni, è vero, ma se lo ricordi deve essere durato per qualche tempo (tu dici “anni”) – i vetri delle finestre della vostra casa di famiglia a Petilia Policastro furono oscurati con pesanti drappi di velluto: eravate addolorati e si doveva vedere. Credo che questo modo di mettersi nel mondo – ecco che uso un verbo creaturale – non può che avere delle conseguenze. Proprio come se ogni volta ci si riposizionasse in relazione a una morte con un po’ meno di vita.
Mamma è sul letto da ormai qualche anno, quasi del tutto immobile, guarda il mondo con uno sguardo orizzontale. Le rare volte che riusciamo a fatica a metterla sulla sedia a rotelle accusa capogiri, svenimenti ed emorragie. Siete fianco a fianco ma lei dorme in un letto da ospedale a due snodi e manovelle che alzano piedi e testa, due spalliere per non rischiare cadute e un materasso anti-decubito. La testiera antica, quasi una parentesi graffa che teneva le vostre vite, è rimasta ma, fuori asse, dà una specie di vertigine innaturale a questa isola battuta da vento e mareggiate del vostro amore coniugale. È merito vostro – e ve lo riconosco oggi senza più nessuna polemica – se amo così tanto la vita. È come se avessi fatto scuola di sofferenza ed è per questo che cerco il piacere ovunque. Un piacere materiale e uno spirituale. Grazie a voi apprezzo le cose. Amo per contrasto. Vivo felicità in contraltare. Vi devo molto per questa lezione negativa anche se è una gratitudine recente, figlia di un modo di sentire la vita per opposizioni felici. Non è stato così sempre. Per un tempo infinito non sono riuscito a pensarmi come una creatura autonoma: infelici voi, infelice io. Al senso della colpa opponevo la causa della colpa e il principio del male era in voi. Da qui: contrasti senza fine, accuse e odio comprovati. Il mio piccolo tribunale ingenuo ma leale vi condannava senza attenuanti. La pena era più mia che vostra perché era una condanna in contumacia. Continuavate a essere quel che eravate e la debolezza della mia sentenza vi soccombeva. Non riconoscevate quel tribunale recente, vi assolveva la forza dell’età e l’ignoranza. Ma come darvi torto? Nessuno riconosce mai la propria condanna e il mondo non è dei ragazzini. Ci sarebbe voluta una rivoluzione interiore per scagionarvi e infatti accadeva senza che me ne rendessi conto, a piccoli passi. Ottusamente accoglievo l’idea che la mia infelicità non era nella vostra infelicità, non era la vostra infelicità. Senza capire accettavo che la rete che tutti unisce può essere tessuta diversamente e che cambiare un nodo di questa maglia che ci tiene uniti era cambiare le implicazioni dolorose di alcune connessioni dolorose. Bisognava pensarsi liberi e fu un distacco felice anche se lacerante. Dovevo spezzare questo legame nocivo, smettere di vivere di riflesso. Ero io che dovevo vedere in quel riverbero di confuso dolore e non voi. Non fu una visione naturale: è sempre più consolante assegnare colpe e condannare che rassegnarsi ad essere gli unici artefici delle proprie sfortune. Partire da me era in definitiva l’unico passaggio che mi potesse mettere al riparo dall’attesa infruttuosa di attendere da voi una soluzione al mio star male per causa vostra. Ma prima che tutto questo accadesse ero già andato via di casa affittando un monolocale attiguo a un centro sociale. Credevo così di mettermi al riparo dopo ventuno anni dalla sconfitta e dal dolore, ma fu inutile. Fu una specie di esilio triste senza il quale, però, non credo sarei riuscito a maturare idee di riscatto. Fu come il passo indietro del leone prima del grande balzo. Fuggire non poteva essere la strada e me ne accorgevo nel rimbombo a vuoto di quel rifugio.

§§§
Che faccia tranquilla ho mentre scrivo su questo tavolo: è come se una ruga fosse sparita, come se qualcosa stesse cancellando una preoccupazione, ammorbidendo un rigore.
Ripenso senza amarezza a come la vita per me abbia destinato finora la sola misura dei trenta-quaranta metri quadri. Se giro lo sguardo in quest’ennesimo ricovero alberghiero – per ora il mio lavoro sembra essere “permettere ai colleghi più maturi e titolati di non abbandonare la sede”, questo dovrebbero scrivere nel mio contratto occasionale – lo sguardo continua a misurare questo standard decimale non dissimile a quello della mia casa di adesso come lo fu della mia prima casa “mia”. In televisione, che tengo a volume zero, scorrono le immagini in replica di gare di atletica leggera. La regia indugia sul culto del vuoto e dell’inutilità che hanno le preparazioni dei saltatori, il vigore automotivante e urlato di quella dei lanciatori del martello e del peso, la vibratoria ossessione per il riscaldamento dei corridori. Su tutto predomina il comune denominatore della concentrazione in questa gamma di sfumature che asseconda la disciplina e le nazionalità. Gli africani sembrano i più compassati o forse solo i più divertiti dal competere, gli americani i più sicuri di loro stessi. I russi sono seri, i francesi sembrano lì per sbaglio, i tedeschi sanno perdere e gli italiani sembrano dover gareggiare due volte. La prima con la sfortuna che è come se gli viaggiasse sempre accanto senza nascondersi ma al contrario palesandosi in tutta la sua irriverenza. Quando la tengono a bada – la paura della sfortuna – sono i migliori di tutti: hanno grinta e sorrisi, morbidezza, rigore, intensità, un po’ di quel fatalismo che non guasta e che fa intravedere anche solo il bagliore di un grande sistema religioso. Ma non è sempre così.
Bisognerebbe tracciare una specie di antropologia a seconda delle discipline e degli sport: pur non avendo un’utilità culturale né scientifica servirebbe a riconfermare e approfondire il retroterra massimizzante delle barzellette. “C’era un italiano, un francese e un tedesco…” Ecco: i luoghi comuni dovrebbero essere disciplinati da una cultura, studiati, ricondotti a leggi precise anche se sommarie: anche l’approssimativa convenzionalità merita la sua esegesi.
Mi alzo per andare in bagno e ritorno, otto passi. Chissà se si può fare una media delle energie che si consumano in una casa così piccola, una tabella di raffronto con abitazioni più grandi. Ho sempre vissuto in case ampie quanto questa stanza d’albergo. Lo sguardo non ha mai faticato ad abbracciarne il perimetro. Ho avuto sempre presente davanti ai miei occhi i luoghi e le loro funzioni. Eppure anche io, e forse proprio per questa penuria, ho provato l’ebbrezza e l’ambizione divertita dell’arredamento. Magari sbagliando, ho fatto una specie di lego dei mobili modificando in corsa e di centimetri l’idea degli spazi. L’avere questa mentalità giapponese della casa – anche se forzata – forse ha reso meno gravosi i miei tanti spostamenti e sono diventato il candidato ideale di queste sostituzioni da trasferta.
§§§
Eri radiologo tu, invece. E poi mio padre. Scattavi ‘foto interiori’, pensavo io. Mettevi gli occhi dentro le persone e facevi clic. Avevi delle loro immagini molto intime. Lastre semitrasparenti nero-azzurre che poi guardavi e riguardavi con i tuoi occhi cerchiati di pelle scura e raggrinzita, rimpiccioliti dalla miopia ma limpidi. “Heureux le myope!” dicevi vantando la tua capacità di vedere nel minimo gli addensamenti che indicizzavano i mali e t’intristivi nel tuo profondo. Maturavi una naturale gravità che poi a fatica si separava da te e da quel che eri: un uomo anziano e grave da sempre e in tarda età giovanile per assurdo e in salute ma sempre anziano. Grigio e saggio, anche nei capelli appena canuti e con rara calvizie. Capelli lisci e ordinati, ravviati dietro la nuca che pettinavi con gesti da barbiere, il taglio della mano a volo leggero sul pelo – guai al contropelo! – e odori dolciastri di Linetti a seguire.
Le persone non avevano segreti per te, arrivavi a conoscerle a fondo più degli altri. Condividevi con loro i dolori ma con me parlavi poco. Anche con me non avevi segreti ma avevi distanze e avvicinamenti improvvisi. Ci siamo voluti bene a singhiozzi.
Ero piccolo, passeggiavamo insieme per le strade di Città Giardino e mi dicevi: “Col poco che hai vissuto puoi credere che tutto il mondo sia già qui. Un momento puoi chiamare questo luogo illusione e poi disillusione. O è energia o è mancanza di energia. E le penserai di volta in volta definitive le tue risposte, assolute. Ti dico che il mondo ti stupirà ancora e che non ti basteranno gli occhi che hai per dire ‘ho visto’. Guarda in alto, per esempio. Vedi quei ciuffi d’erba e piante tra le tegole? Non hanno terra (oppure è terra la sabbia deposta dalle piogge d’Africa?). Sono i segnali di una vita imprevista, creature di un mondo che non riconosci come mondo. Intendo questo per ‘mondo nuovo'”.
Non so se ho mandato a memoria bene le tue parole o ho inventato una saggezza per il ricordo di te ma mi torni alla mente riflessivo, qualche volta saggio. Di te mi piaceva anche la fantasia degli occhi che guardavano le cose. Per esempio quei tubi intestinali a metà tra i paesaggi lunari e le sagome degli animali nelle ombre cinesi. Impettito nella tua tunica di piombo su sfondo verde-acqua, dopo aver a lungo osservato al negativoscopio declamavi la tua arringa: “le flessure son ben dissociabili; solo il tratto di passaggio retto sigmoideo mostra un’inflessione scarsamente dispiegabile nelle varie proiezioni”.
Era una prosa ellittica che in gioventù rammento registrata su un vecchio Geloso orizzontale a bobine. Memoria forse tua di collegiali recitazioni corali, risuonava in un’armonia cupa e scandita, quasi battuta ad accenti come se li componessi a metri i tuoi referti, per la segretaria che li traduceva in inchiostro e schiocchi a doppia copia (una velina per te e un extrastrong per i clienti) e carta carbone. Gli schiocchi furono Remington a mani tamburellanti e incertezze seguita da Olivetti elettrica di suoni a mitragliatrice. Io, salopette di jeans e fiori a rilievo, rosette al provolone dolce e i Provolino e Zagor, i Topolino e poi i Monello, che aspettavo nella sala d’attesa. Ero in attesa anch’io di te. Mi aspettavo qualcosa anch’io da te. Nel momento sbagliato e sbagliando attendevo da altri quel che solo io avrei potuto ricavare da me: un errore fatto e rifatto a noia e con molti altri dopo di te prima di capire il segreto.
Una volta hai fotografato persino dieci lire in un tubo tracheale per tranquillizzare pazienti poco attenti a figli struzzi e scalmanati.
I tuoi libri erano pieni di corpi a segrete immagini su fogli lisci e fragranti, con rilegature costose che aspettavano anche loro i tuoi occhi neri e il gesto della mano che disarciona gli occhiali dalla soma dell’orecchio. Cavalcatura di gran lunga preferibile invece quella in tartaruga e fondi di bottiglia, indispensabile ad esempio per i viaggi nel parabrezza. Vorrei che ci ricordassimo così di noi: nella vecchia 124 bianca. Io, tu e la pecora da giovane. Ce ne tornavamo da Pescina, città di Silone dove avevamo avuto dalla macellaia Maria la bestiola che ora ci portavamo nella nostra casa marsicana tutta mandorle, visciole e mele e pere acri sperando che ci rallegrasse l’agosto. La pecorella belò per tutto il viaggio, in piedi nel recinto di una scatola di cartone. Le viaggiavo al fianco dividendo in parti uguali il sedile posteriore e sperando in una grande futura amicizia. D’un tratto l’animale, giovanissimo, fece un goccio d’acqua emozionato tra tutti quei belati e io per paura che ci sentisse ti sussurrai all’orecchio l’accaduto con tua ilarità grandemente affettuosa per la mia cautela.
Ci si voleva bene per benedetta involontarietà mentre a conti fatti si guerreggiava senza tavoli d’intesa e con malumori. Ci sopravveniva una consonanza di tanto in tanto che ci muoveva commozioni e affiatamenti provvisori di cui non ci saremmo mai accontentati.
§§§
Mia madre, una donna. Sembra un’evidenza. Eppure quando penso a noi – a me e a te, a me con te, mamma – negli anni dell’infanzia non penso a quest’assioma ma alla sua negazione. Ho cinque o sette anni o forse più e non ho questa perentorietà genetica. Non la ho ora nel ricordo o non ricordo di averla avuta. Donne sono, semmai, le mamme degli amichetti di allora. Donne sono quelle che vedo per strada. Donne sono alla televisione. Ho cinque o sette o dieci anni e penso che mia madre non è una donna. Oggi ricordo con esattezza quella convinzione che – non c’è bisogno della biologia – è ovviamente un assurdo che non ha bisogno del mito di Edipo per essere sconfessata o problematizzata. Ripenso all’album delle foto. I vestiti sono i vestiti di allora: colori sin troppo fulgidi, forme un po’ troppo geometriche dei tessuti di quegli anni, un po’ di fiori ogni tanto ma non troppi (i fiori sono nelle foto di qualche anno prima, quelle che vedo nell’album mozzo della vita dei miei di prima), il corpo che si è fatto più grande. L’aria di una signora, quindi, ma in incognito. Mia madre, niente più.
Cosa c’è di diverso tra te e le altre, quelle che inequivocabilmente riconosco come donne? Non ho verso di te protezione, o gelosia: sono sentimenti di cui non sono capace o non ricordo di esserlo stato. A questa sensazione si aggiunge la percezione di un senso ulteriore che esprimono spesso le vite dei santi, le storie degli illuminati in relazione alle loro famiglie naturali. Come se fosse possibile nascere e vedere con chiarezza nell’atto natale un tramite. Una specie di predestinazione, una causalità che, allo stesso tempo, finisce per cancellare tutte le implicazioni parentali. Non sono nato come un figlio ma come una figura storica o ultrastorica. Mi percepisco in una leggenda, una fiaba che potrebbe essere raccontata senza suggestioni famigliari ma nella simbologia di un rito pur senza avere nessun misticismo o potere soprannaturale. “Morta là” si dice. “Nata là” chioserei. Sono nato e basta. Da quel momento in poi – non che mi mancasse l’affetto genitoriale – mi sono percepito nella Storia. E non nella storia famigliare. Per qualche tempo, come comune nei bambini, devo anche aver pensato di essere stato adottato e se anche sono arrivato a chiederne conferma non era con paura che mi avvicinavo a quel segreto ma con una mia certezza, quasi cercassi la prova della mia estraneità. Non lasciare spazi ai dubbi – come si affrettano a fare tutti i genitori – non era tranquillizzante, nel mio caso, bensì deludente. Mi sentivo ingannato – ora ve lo posso confessare – e tradito, rallentato nella mia ricerca. Ero figlio vostro, non c’era dubbio, cosa vi potevo rimproverare? Ero io che non mi sentivo adeguato a questa ascendenza, non certo voi.

§§§
Guardo le foto del prima. L’album vi impressiona in viaggi avventurosi. L’avventura è pure nelle vostre parole che li raccontano. Parlano di fienili per riparare a una notte senza ricovero in Austria – ma quella era l’estate successiva del matrimonio: agosto 1956 – e, conoscendo la vostra poca dimestichezza con la vita “sopravvissuta”, sarebbe da non crederci. E invece, in barba ai pacchetti da tour operator, siete lì: in mezzo a mucche e campanacci, a risparmio già dall’alba della vostra vita insieme. Braccia sui tavoli e teste reclinate: ecco che certe notti devono passare senza quella grazia che si attende dal viaggio di due sposini. Nessuna prenotazione, come va va: ecco il vostro amore in itinere.
Il viaggio di nozze ritaglia due piccole ma meravigliose italie, quella delle Cinque Terre che avremmo amato insieme – tutti e quattro – e poi avrei continuato ad amare da solo e quella della Costiera amalfitana. Anche in quel caso nessuna prenotazione ma forse nessun fienile. E nessuna foto, comunque. Le immagini vi ritraggono nell’agosto che segue tra Moena e altri scorci alpini. Mamma è bellissima, le gambe raccolte ad angolo in una seduta molto elegante e fuori tempo vista dall’oggi, guarda piccoli meravigliosi laghetti circondati di abeti, un maglioncino da cui spunta il colletto di una camicia da educanda. Ha uno sguardo sereno mentre nell’unica che vi mostra insieme tu, papà, hai l’aria corrucciata, la stessa che si intuisce dalle lettere dell’anno che precede il matrimonio.
Tu eri in giro per l’Italia (Bari, Roma, Firenze, Genova) sorpreso dalla guerra mentre ultimavi l’università e ti specializzavi. Mamma era a Catanzaro, senza più studi e in attesa dell’ultimo gradino che era destinata a salire della sua vita: quello del matrimonio, della famiglia e della casa, come un’unica tripla mossa, una specie di scacco matto che chiudeva la sua partita col futuro. Vi scrivevate per riconfermare una promessa, con amore. Un amore responsabile, quasi destinato, un amore che non si fa domande, piuttosto afferma.
Le tue erano lettere interrotte da continue cancellature. Affetto-scarabbocchio-amore: è in questa specie di formula faticosa dell’abbandono che si riassume la tua complessa personalità. Fatta di malumori, rancori, capricci (nel leggerti con tanto rincrescimento ritrovo me) e solo dopo abbandoni o concessioni. Ma mai senza prima “bronci” come li chiamerà mamma in risposta, piegandosi, prima delle numerose volte, alle tue richieste e al tuo abbandono al ricatto. “Non serve a niente tenere questi bronci” e si piega. Eri irritato da un mancato appuntamento telefonico – mamma era stata comandata a fare visita a un parente – e decidevi di interrompere la corrispondenza e di sfogare in una successiva lettera collerica tutta la tua contrarietà.
Fu così anche dopo: tu imbronciato e mamma che offriva il fianco della pace. “Beh… facciamo un caffè dell’amicizia?” e le tazzine sempre pronte in cucina si ravvivavano per diventare lo strumento di una ricomposizione, impossibile senza la sua intraprendenza. Noi scherzavamo, ci sembrava un pretesto per la tua dipendenza da moka, ma chissà quanto futuro insieme dobbiamo a quella frase conciliativa, al gorgoglio in salita della vostra bevanda di armistizio.
§§§
Ecco la cerimonia del matrimonio. Sei magra, bellissima, mamma. Nella foto, a guardarti, sembri del tutto inconsapevole del gesto che stai per compiere (sono le foto del fidanzamento) o hai compiuto (è il viaggio di nozze). Un sorriso appena accennato che marca però felicità. C’è qualcosa di prodigioso nella consapevolezza di chi sta per dire un sì per sempre ed è questo ricordo mitico che sembra risuonare nelle tue parole per quell’appena prima. Quel prima che con un gesto e poche frasi ti traghetterà in un mondo diverso. La “vita insieme”.
L’attendere è la tua caratteristica, mamma. E lo è da subito. Una promessa di matrimonio e poi silenzio per quasi due anni: papà che con abnegazione e senza negoziazione o riscontri prepara quel passo. In solitudine. Tu che aspetti, papà che predispone e poi si rifà vivo a cose sistemate. Secondo lui, sistemate. Solo da allora si può parlare di fidanzamento anche se vi scrivete lettere come prassi e considerate questo tempo come fidanzamento. Tu scrivi “serenità”, scrivi “tranquillità” ed è a papà che parli. Gli consigli di occuparsi serenamente del suo lavoro e tu ti occuperai della casa: il progetto è chiaro; non è solo scontato, è deciso, voluto, predestinato. S’intuisce che a te costerà: l’abbandono della famiglia, dell’amata casa paterna, della città in cui sei nata e vissuta. Hai deciso di dedicare a papà la vita e lo dici senza risparmio ma molte delle energie devi destinarle a tranquillizzarlo dalle sue ansie. Quella dello studio – si sta specializzando in radiologia, tra Firenze e Roma – quella di non meglio precisate imposte famigliari. Ma, prima di queste, l’ansia è quella del sentirsi, del ricevere le lettere con precisione (da come leggo partono in un giorno e arrivano nel successivo coprendo la distanza Firenze-Catanzaro) del riuscire a parlarsi per telefono alle ore prestabilite. Scrivi e intimi la tranquillità, la serenità che forse già avverti vacillare in un giovane indebolito dall’essere orfano, dalla conseguente forzata vita collegiale e da tutorati di severità senza amore. Cerchi di farlo pensare al futuro, alle cose belle, ma lui si concentra sulle mancate coincidenze e tu mamma con giochi di equilibrati eufemismi lo rimproveri “sei terribile!” in relazione al broncio derivato da quel mancato appuntamento via filo. Usi molti punti esclamativi e dici anche delle cose divertenti: in una lettera ti definisci “esclusivista”, in un’altra rimproveri le margherite di “essere bugiarde” e di avere i petali in numero paro e architetti di togliere un petalo prima di iniziare lo spoglio. Nelle pagine – sono quello che oggi, in tempo di fotocopiatrici, si definirebbe un foglio A4 piegato a metà –, scritte in una grafia quasi sempre ordinata e corretta, vergate con una biro blu in cui vincono le intenzioni, la dedizione il “non vedere l’ora”, l’attesa e la promessa. L’incoraggiamento a questo spaurito giovane sempre in preda alla preoccupazione per qualsiasi cosa.

§§§
Ti ho letto le lettere. Tu ascoltavi in silenzio e proiettavi l’occhio buono (l’altro, colpito dalla paresi, era chiuso da un cerotto) in un punto imprecisato, oltre i piedi del letto. Ogni tanto mi fermavo e ti chiedevo qualcosa per assicurarmi che non dormissi. Appena un sì e proseguivo. Mano nella mano andiamo nel tuo passato, lì dove sono solo un’intenzione che ancora non sa delle tante fatiche, degli anni di attesa, degli ormoni lanciati nel tuo corpo per renderlo fruttuoso. Scrivi la tua felicità futura senza conoscere l’ostacolo del tempo e della vita. Vuoi essere una madre, vuoi essere una moglie senza sapere quanto sarà difficile tutto questo. Senza ancora immaginare tutti gli esami e le analisi che per dieci anni ti daranno sterile. Non pronta ad accogliere la vita che hai tanto desiderato. Se c’è una metafora vera nell’annunciazione evangelica deve essere questa: si riceve un dono, si è un tramite da sole. È come se da quel momento – il momento della pregnanza – la donna è sola. Solo lei è l’albero.
Leggo le lettere, cerco indizi di me. Non c’è un’ecografia, una prova video del mio essere nella tua pancia. Non c’è una foto della tua pancia. Non si fotografa una donna incinta: forse per scaramanzia. Si attende la nascita e dopo la nascita – come se si pensasse che i bambini non nascono belli – si aspetta qualche mese.
In una pellicola 8mm, che abbiamo riversato in digitale, ho trovato un presepe del 1967 che attendeva il mio arrivo a giorni ma tu non c’eri, mamma.
Il Natale 1969, come diceva un bigliettino in sostituzione del puntale dell’albero, non mi mostrava per limiti di età. Ma, di nuovo, non c’eri neppure tu, come sopravvenuta da nuovi incarichi.
Le prime foto mi trovano sull’orlo di un precipizio, imprigionato in un seggiolino. Sono stato appoggiato su un muretto a strapiombo sul nulla di una vallata. Sorrido, ignaro. L’album che contiene le mie foto è un album mozzo. Nessuno scatto prima degli otto mesi e una certa vostra ritrosia a parlarne.
Ho letto una ventina di lettere tue (e una solo di papà), ognuna nella sua busta, ordinate (dunque papà le ha conservate con tutta questa cura? e tu forse no?), poi le ho risistemate nel vecchio cofanetto Sperlari che le custodiva e le ho riposte nell’armadio. Hai richiuso gli occhi.
Dormi?
No, non dormo – hai detto con una perentorietà e una completezza d’annuncio che forse significava “come si fa a dormire dopo tutto questo!” – e sono uscito dalla stanza. Forse ti ho lasciata al tuo film del tempo.
§§§
Credo che sia una tradizione o forse solo una consuetudine dura a morire ma i loghi degli alberghi sembrano voler inseguire la vetustà degli stemmi nobiliari. Solo tempi recenti stanno dando pane ai grafici e per mezzo loro conosciamo icone più sobrie e inventive, persino di spericolata fantasia.
Gli hotel non sono più casate in cui ci si sente generosamente ospiti. Non c’è più tutta questa distanza. Dall’alto della carta delle ricevute o da questa intestata su cui scrivo non ti fissano più scudi, spade, elmi, rami d’alloro. Scrivo sotto un martin pescatore. Forse è la bellezza della perfetta serigrafia del suo piumaggio che mi convince a tenere in questa carta bianca i miei pensieri, il ricordo di voi, la voglia di parlarvi, o forse il numero dei fogli… ma scrivo con urgenza.

§§§
È la pelle del restare a casa la tua, quella di chi non conosce più la strada e in questa lontananza dalla vita all’aperto apprende una mollezza non solo esterna. Ti stai facendo una bambola di seta. Non ti ricordo mani così. Piuttosto le screpolature dell’inverno, il nero dei carciofi e il gesto di passarci il limone sopra come una saponetta per smacchiarlo. La manovra del togliere i guanti dopo aver lavato i piatti, facendo lo schiocco della mazzafionda nel rivoltarli per poi risoffiarci dentro e riportarli al dritto. Qualche schiaffo ben assestato, cucire, fare orli, sbattere le uova, scrivere la lista della spesa con una grafia imperiosa e arcaica, sciacquare i bicchieri pigolanti, grattare le croste dalle teglie, aprire la lavastoviglie tintinnante o il forno stridulo e dire “ho fatto il ciambellone” cercando di procrastinare la gola, mistificando l’afrore che già ce lo aveva fatto pregustare.
Le mani di oggi non pelano più patate, né fanno il m’ama non m’ama con i carciofi. Non più fornelli, né ferro da stiro, né ago e filo. Se ne stanno lì quiete: al massimo indugiano sul ricamo delle lenzuola. Il resto è immobilità.
Le gambe, avvolte in garze e bende, rimangono tutto il giorno allineate al dolore e al letto. Si sono fatte due zeppi smagriti. Carne sempre al sangue, mangiata una volta per tutte. Pelle senza ricrescita. Vista da sotto sembri una mummia ma guardare sotto l’Egitto delle tue fasciature è un’esperienza di dolore.
Solo una volta ho avuto il coraggio di scoprire cosa possono fare le ulcere al corpo, che lavoro diffuso e continuo, senza tregua, possono portare a compimento, invincibili. Senza il prestigio sicuro di quelle malattie dai nomi altisonanti, le statistiche e gli allarmi dell’organizzazione sanitaria mondiale: la tua malattia sembra solo tua – un piccolo primato doloroso – e non gode dei riflettori. Una delle volte che sono venuto a trovarti all’ospedale ho saputo con rincrescimento che eri detentrice di un record e che nessuno aveva mai visto ulcere da vene varicose così diffuse, né così resistenti alle cure. Ho capito che in più di un campo la scienza e la medicina brancolano nel buio ammantandosi di certezze che di volta in volta si rivelano fallaci. Il laser, trapianti di pelle, connettivina, gel, pomate, pillole, placche. Hai fatto da cavia a tante sicurezze in camice bianco. Inutilità travestita. Le ulcere erano sempre lì. Sempre diffuse, sempre dolorose. E tu te le portavi dietro con l’aria rassegnata e mite che hanno i santi o i beati. Il tuo martirio meriterebbe immaginette con dietro preghiere, gigantografie a pendere e piazzali di gente in attesa. Non sono io a dirlo è l’impressione di chiunque guardi quel tuo volto serafico in faccia al dolore. Il silenzio spesso immobile e solo raramente tremante – di un tremolio che pare del tutto involontario e persino contrastato – con il quale ti disponi alla pulizia della carne viva. Un’operazione che sembrerebbe sadica per la solerzia straziante degli infermieri nello staccare garze ormai quasi assorbite dal corpo e per l’insistenza da cesellatori del grattare le ferite per renderle più pulite. Solo la soluzione fisiologica sembra la panacea di questo spargimento di sangue e dolore a fin di asepsi.
Ecco come fa il tempo. Prende e mangia. Fa così. Inizia dove trova carne. Inizia a mangiare da lì. Logora, rosicchia. E irride. Si fa beffe e s’inebria. Il tempo fa così. Scrupoloso, lento, silenzioso. Lavora bene. Non chiede aiuto né si sente perso. Il tempo fa bene quello che deve fare, meglio di come ti aspetteresti. Non ha la nostra mediocrità, le nostre incertezze. Non rimanda a domani. Compie nel giorno. Si concentra nell’ora, e lavora. Che invidia! Che vacuità la nostra dissipazione!