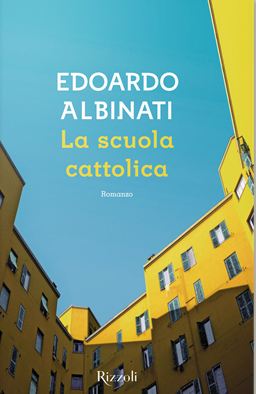Questa recensione a “La scuola cattolica” (Rizzoli) è uscita sul Domenicale de “Il Sole 24 Ore”. La ripubblico in occasione del Premio Strega 2016 al suo autore Edoardo Albinati.
Edoardo Albinati è, forse, il più bravo di tutti. E lo è stilisticamente, narrativamente, drammaturgicamente, lo è come ritrattista, etnologo urbano, mitografo di idee. Ora, in questa luccicante bravura – dispiegata in ogni pagina, in ogni singola frase della Scuola cattolica (Rizzoli, 22 euro, pp. 1294) – potrebbe però nascondersi un “problema”, come dirò tra poco.
Con questo libro la migliore prosa d’arte (si veda di Albinati la perfetta “Serenata al rettilario” nella sua raccolta di racconti Guerra alla tristezza), devota agli ideali di elegante precisione, ritmo musicale ed essenzialità, incontra la forma liquida del romanzo-contenitore (oggi quasi lo stile del mondo), dello zibaldone digressivo e dissipatorio, e così implode. La scrittura insegue meticolosamente la instancabile flânerie mentale e fisica dell’autore, le sue passeggiate per il QT (Quartiere Trieste), gli innumerevoli personaggi del suo “romanzo di formazione”(amici, compagni di classe al San Leone Magno, sorelle dei compagni di classe, fratelli dei compagni di classe, insegnanti, amori), e poi incontri, letture, pensieri svagati, interrogativi, esitazioni, tradimenti, successi, disfatte… Delle tre grandi aree – o tipi della interrogazione – in cui Calvino aveva suddiviso il suo Palomar c’è qui molta Descrizione (memorabile quella delle abitazioni borghesi, oscillanti tra il nascondere e l’esibire), molta Riflessione, però quasi sempre esemplificata in qualche concreto personaggio (nel testo sono come incastonati tanti microsaggi sulla scuola, sull’amicizia, sul fascismo – che tiene insieme “legge e trasgressione” – sul femminismo, sul masochismo, sui sogni ad occhi aperti degli adolescenti, sull’eros e la “volubilità” del pene…) e un po’ di Racconto, quel tanto che viene ispirato da fatti realmente accaduti (Albinati probabilmente condivide la diffidenza di Garboli verso i vapori della finzione e il conseguente pregiudizio positivo nei confronti della realtà, sempre più misteriosa, inafferrabile e imprevedibile di qualsiasi nostra storia immaginata: “è più facile scrivere quando si scrive la verità”).
La stessa rappresentazione del DdC (Delitto del Circeo) – non solo prodotto di tempi ma “produttore di tempi” e di costume -centro magnetico del libro, e suo primo movente, è alla fine solo uno dei molti temi, sullo sfondo di un potente affresco sulla Classe Media, incerta se sopraffare o sottomettersi, dotata di un buon senso che viene meno quando si sente più sicura. E probabilmente è una meditazione sul male quella che ispira ogni pagina, con una intuizione fondamentale – direi di ispirazione dantesca – a proposito delle “logiche” elucubrazioni degli assassini: il male non ha a che fare tanto con la “bestialità” quanto con il calcolo e con una ragione interamente ridotta ai suoi piani e progetti.
C’è poi una pagina decisiva che involontariamente ci offre una chiave di lettura della Scuola cattolica. Quando l’autore confessa che sì, lui poteva anche credersi il più intelligente (beninteso dopo l’inarrivabile Arbus), ma “sempre come potenzialità piuttosto che per effettive realizzazioni”, e aggiunge di sentirsi sempre magnificare per “il libro che potrei scrivere”, non per quelli che ha scritto. In genere è sempre al di qua di ciò che vorrebbe o potrebbe essere, lievemente spostato: in chiesa pensa a tutto tranne che alla religione, negli anni ’70 si dichiarava comunista senza minimamente esserlo… E anche La scuola cattolica, nonostante la mole intimidatoria delle 1300 pagine (avvertenza: a pagina 520 l’autore stesso autorizza a saltare qualche capitolo), si potrebbe leggere come un faraonico abbozzo, la prova generale di un romanzo che non c’è, che avrebbe potuto essere, ma che verosimilmente non sarà mai scritto.
Accennavo alla presenza di un “problema”. Non c’è pagina del libro in cui Albinati non ci mostri la sua inesauribile verve intellettuale, il gusto del paradosso e della battuta arguta, il calembour, l’aforisma (“l’amore è la tomba del matrimonio”, “il cattolicesimo antesignano del surrealismo”), la istantanea fulminante (l’ora di nuoto, con quei corpi pallidi e malfatti, come “un livido quadro manierista”), leggende metropolitane ed elenchi (di film, frasi fatte, etc, un po’ à la Veronesi), il commento al tic linguistico (“embè” è “la formula cui è impossibile replicare”), la evocazione lirica (ad ogni mese estivo vengono associati colori e suoni: “Agosto: Bruciato Bianco Polvere e Vuoto”), il rovesciamento spiazzante del cliché, con risultati spesso virtuosistici (anche se l’analogia tra le due povere vittime del Circeo chiuse nel baule e il gatto di Schrödinger, morto e vivo al tempo stesso, è un po’ fuori controllo).
Mai una osservazione di senso condiviso, appena un po’ banale, ordinaria. Come se lo scintillio della prosa e dell’ingegno fosse una specie di ipnotica coazione, o perfino uno schermo che protegge dal caos del mondo. L’io narrante in ciò potrebbe somigliare all’Ulrich dell’Uomo senza qualità: uno spirito iper-analitico, vivisettore, alla giusta distanza dal male che racconta, “trituratore” di libri, attratto dal “senso della possibilità”, in genere incline a fare più esperimenti che vere esperienze, dunque sempre aggressivamente sulla difensiva, con un proprio nucleo statico e inviolabile. Ciò che qui si riconosce alla Borghesia come sua mentalità specifica – distacco e distanza, formalismo, “dare del lei” anche alla morte e alla malattia – viene fatto proprio, quasi
omeopaticamente, dall’autore stesso per mostrare il cuore di tenebra della Borghesia, per “darle del lei”.
La scrittura diventa l’esercizio continuo, affilato, “spettacolare” – non c’è mai un attimo di noia – di un io accogliente ma anche sorvegliato, dispotico, che aspira a evadere da se stesso e mutarsi finalmente in cosa, che tuttavia non intende mollare la presa intellettuale, che trasforma anche lo svenimento in mito letterario (in un libro precedente), che ama il rischio solo potenziale, che ci offre una variopinta galleria di personaggi – una commedia umana su cui si piange e si ride -, che incarnano tante possibili figure del destino, ma nei quali lui non si dimentica mai, come invece farebbe un romanziere. All’inizio si dichiara, con onestà, “felicemente infelice”, perché non può che trasmetterci la nostalgia di una felicità perduta, di una pienezza che “si gode solo in un secondo momento”. E probabilmente solo nella scrittura quella felicità, allora appena sfiorata, volatile come l’abbraccio di una donna, ritrova la unica sua dimensione tangibile, meno effimera.