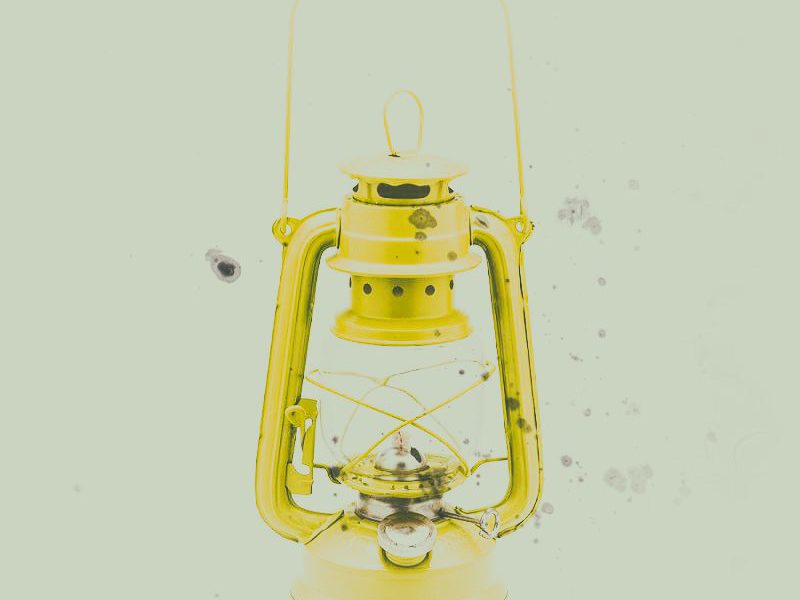La lanterna. Un ristorante in cui purtroppo non mangerò più.
Qualche sera fa ho cenato in una pizzeria in cui non vado quasi mai. Al tavolo accanto al nostro c’era una famiglia composta da tre persone: padre e madre piuttosto anziani e la figlia ormai grande, una giovane donna.
Al momento dell’ordinazione la figlia ha raccontato al cameriere che l’ultima volta che era andata a cena lì si era poi sentita male per tre giorni e questo a causa del pepe nel sugo della pizza.
Il cameriere, dal canto suo, assicurava che nel loro sugo non c’è pepe. La giovane donna sosteneva che il pepe era sicuramente caduto per sbaglio nel sugo e poi ordinava una pizza margherita. “Mi raccomando: senza pepe”.
Mentre la donna e il cameriere parlavano mi ponevo mentalmente alcune domande: come è possibile che qualcuno si senta male per tre giorni a causa di un po’ di pepe caduto per sbaglio nel sugo della pizza?
Come faceva il cameriere a escludere con sicurezza la presenza di pepe nel sugo? (Ho lavorato in un ristorante per qualche tempo e so che i camerieri non conoscono così in dettaglio le preparazioni dei cibi che portano poi a tavola).
Perché quella famiglia, nonostante lo spiacevole episodio, aveva comunque deciso di tornare a cena in quel ristorante? Mi ha sempre affascinato la categoria umana dei “delicati di stomaco”. Io sono uno struzzo.
Ho i miei gusti, è chiaro, ma mangio di tutto, assaggio di tutto. Non sono schizzinoso: a Shanghai, per esempio, ho mangiato in piccole friggitorie ambulanti in cui era meglio non farsi troppe domande sulla pulizia personale di chi cucinava, delle pentole e dei mestoli, dei ripiani e dei contenitori degli ingredienti…
Eppure c’è gente che sta attenta a queste cose, che sta male tre giorni per un po’ di pepe caduto per sbaglio nel sugo della pizza (che le cose siano andate davvero così è irrilevante: quella giovane donna era convinta di questo, e a me è questo che interessa).
Mentre la cena continuava guardavo discretamente cosa aveva ordinato la famiglia al tavolo accanto: tutte cose estremamente semplici. Pizze margherite, appunto, niente vino o birra, ma acqua minerale naturale. Niente per dolce. Solo il padre ha preso una fetta d’ananas.
Da qualche anno a questa parte mi sono reso conto che per me andare a cena fuori per diletto significa soprattutto andare a mangiare cose che non sarei in grado di farmi a casa.
Io sono piuttosto bravo a cucinare, ma certe preparazioni sono comunque complesse. So fare il sushi, ma al ristorante giapponese sono più bravi di me. Non ho un forno tandoori a casa, dunque ogni tanto mi fa piacere andare al ristorante indiano.
Non ho un forno a legna e quindi, se voglio mangiare una pizza cotta nel forno a legna, devo per forza andare in pizzeria.
Invece c’è gente che quando va a cena fuori tende a ordinare le cose che mangia abitualmente. La pasta. C’è gente che va al ristorante e ordina la pasta, che per me è una cosa abbastanza assurda (siamo italiani e anche chi sa cucinare poco o nulla è in grado di scodellare un piatto di dignitosi spaghetti al pomodoro).
Ma al di là di questo mi rendo conto che quando decido di andare a pranzo o a cena fuori preferisco sperimentare un posto nuovo anziché tornare in uno in cui sono già stato (anche se mi sono trovato bene).
Ci sono solo un paio di locali in cui torno abitualmente e lo faccio più per motivi personali che legati all’offerta gastronomica. Eppure anche io, quando ancora vivevo con i miei, ero un abitudinario delle cene fuori. Per moltissimi anni, non saprei dire quanti, mio padre, mia madre ed io siamo andata a mangiare la pizza sempre nello stesso posto: la pizzeria “La lanterna” di via Luigi Solidati Tiburzi, che è il ristorante perduto di cui parlo oggi, dopo la lunga premessa.
C’erano altre pizzerie nel quartiere, più o meno alla stessa distanza da casa nostra, ma si andava sempre alla Lanterna. Quella pizzeria ha chiuso all’inizio degli anni Novanta, mi sembra di ricordare. Da trattoria-pizzeria che era si è trasformata in un ristorante con qualche velleità in più (fu rilevata da uno dei proprietari di una delle rosticcerie-tavole calde storiche del quartiere che ancora porta alta la bandiera dei migliori supplì della zona).
Poi anche quell’esperimento finì. Adesso credo ci sia sempre un ristorante, ma sono anni che non passo più per quella stradina.
Alla Lanterna ci sono andato a cena per anni, prima da bambino con i miei, poi da ragazzino, infine da ragazzo, a volte con i miei altre volte con gli amici, prima che cominciassimo ad avere l’età per stare fuori più a lungo la sera con la possibilità di mangiare al centro di Roma anziché accontentarci dell’offerta del quartiere.
Quando ci andavo con i miei si ordinavano sempre le stesse identiche cose: i supplì per antipasto, poi la pizza. Io rigorosamente la capricciosa (una pizza che ormai non ordino praticamente più) e i miei la napoletana. Da bere birra. Poi l’immancabile gelato che era il tartufo bianco o nero o i sorbetti al cocco o al limone dell’Antica Gelateria del Corso. A mano a mano che crescevo ricordo che divenne uso ordinare una seconda pizza da divedere a metà con mio padre.
Ho ancora ben presenti le persone che lavoravano lì. Il titolare e suo genero servivano in sala, in cucina c’erano le mogli dei due. Queste persone hanno visto me crescere e io ho visto loro invecchiare. Poi il ristorante cambia gestione e questi volti così familiari scompaiono dalla tua vita. Chissà dove sono ora, cosa stanno facendo.
In queste cose che scrivo, raccontando di ristoranti perduti, sono ben consapevole di sfiorare, a volte di toccare proprio, sgradevoli toni nostalgici, ma il richiamo che esercitano su di me questi ricordi è molto forte. Mi affascina – e mi spaventa al tempo stesso – la ripetitività del lavoro gastronomico. Anni e anni e anni e anni di mozzarelle fatte a dadini, di olio messo a scaldare, di pizze al tavolo cinque, di «Il conto, per favore». «Arriva subito».