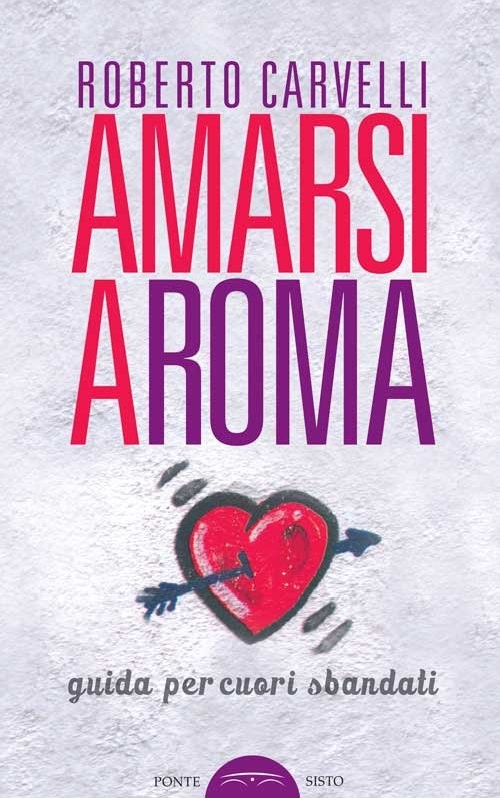“I sampietrini: capra e cavolo” è uno dei racconti che compongono “Amarsi a Roma. Guida per cuori sbandati” che riesce per Ponte Sisto in una nuova veste grafica.
I sampietrini: capra e cavolo
Che strana storia quella dei sampietrini! Durezza lavica che si consuma a forza di passi e ruote e fa una faccia di pelle morbida come un guanto, una saponetta che, bagnata, diventa pista di pattinaggio. Anni fa intervistai uno degli ultimi posatori di sampietrini e insieme a lui uno dei vecchi. In realtà nessuno dei due operava più: il primo, il “giovane”, una cinquantina d’anni, aveva cambiato occupazione, mentre il vecchio era in pensione. Chi me li avevi segnalati aveva sbagliato il tempo.
Si erano conosciuti (all’opera) su ponte Cavour, poi si erano persi di vista e la mia telefonata li aveva rimessi vicini a dire che questa dismissione che si era decisa era un errore e che “se il lavoro è fatto a regola d’arte, la base ben preparata con sabbia di fiume come si usava prima o con una specie di cemento, i sampietrini presentano più vantaggi che altro. Durano almeno trent’anni se non più, fanno filtrare l’acqua e che se ci sono avvallamenti la colpa è di tutte queste squadre di ragazzetti che ha sostituito la tradizione dell’esperienza delle vecchie cooperative di selciaroli”.
Quelle che si erano formate nell’Ottocento per sostenere la grande richiesta di pavimentazioni nella Roma giovane capitale, come quella abruzzese di Alfedena che operava nelle cave di basalto sulla Casilina, nei pressi di Montecompatri. Dai due operai avevo saputo le tecniche certosine della posa con il filo e la livella, l’esagono di partenza che si allarga a cerchi concentrici, i gesti tra il vigoroso e il meticoloso che ne guidano la sistemazione e poi la battitura erculea che va eseguita con il pilone, un mazzapicchio di legno di più di 15 chili, e rifinita con un martelletto. L’uno e l’altro ricordavano il lavoro con un misto di nostalgia e cayenna. “Siamo, sono rimasti in pochi a saperli tagliare a mano e solo sette o otto ditte a Roma di operai esperti nella messa in opera”.
Ho scoperto che quello che a noi sembra un tappeto di selci più o meno uguali è, in realtà, la disposizione di sampietrini di tre tipi in base alla misura. Uno di 12 per 12 per 18 centimetri, rastremato in basso, un altro di 12 per 12 per 6 e uno rarissimo di 6 per 6. Ho cercato di pensare a piazza Navona, ma non mi ricordavo la differenza di questi tasselli più brevi. Mentre avevo presente le piazze non più nere ma marrone chiaro di un porfido ormai non più italiano – loro dicevano napoletano – ma di Hong Kong e, erroneamente, catalogato nella stessa famiglia di pietra romana che invece finisce nelle ville dei ricchi.
I sampietrini sono l’elaborazione di un tempo, una eredità scomposta. Nascono come pezzi rotti del basolato che lastricava le consolari romane Prenestina e Tiburtina, vie nel frattempo cadute in disuso. Un’operazione di cuneo e taglio che si faceva dal XV secolo, vero Medioevo di Roma, di una fatica almeno più leggera del lavoro di cava per estrarre la selce ai Colli Albani dalla colata piroclastica di Capo di Bove formatasi circa 280 mila anni fa. Un’archeologa che ho intervistato mi ha parlato della Confraternita di San Pietro. Secondo la sua personale etimologia il nome della pietra verrebbe da lì, da questa influente divisione pontificia e dalle sue prime pose di selce davanti alla basilica vaticana.
Difficile dire che ne dovrebbe essere di loro, dei sampietrini, tanto vituperati e, d’altro verso, tanto adulati. Senza i cubetti di selce Roma non sarebbe più la stessa e quindi si dovrà, con buona pace delle legittime proteste dovute ai disagi della circolazione, salvare capra e cavolo relegandoli alle aree pedonali o di poca circolazione di auto e – soprattutto – moto.