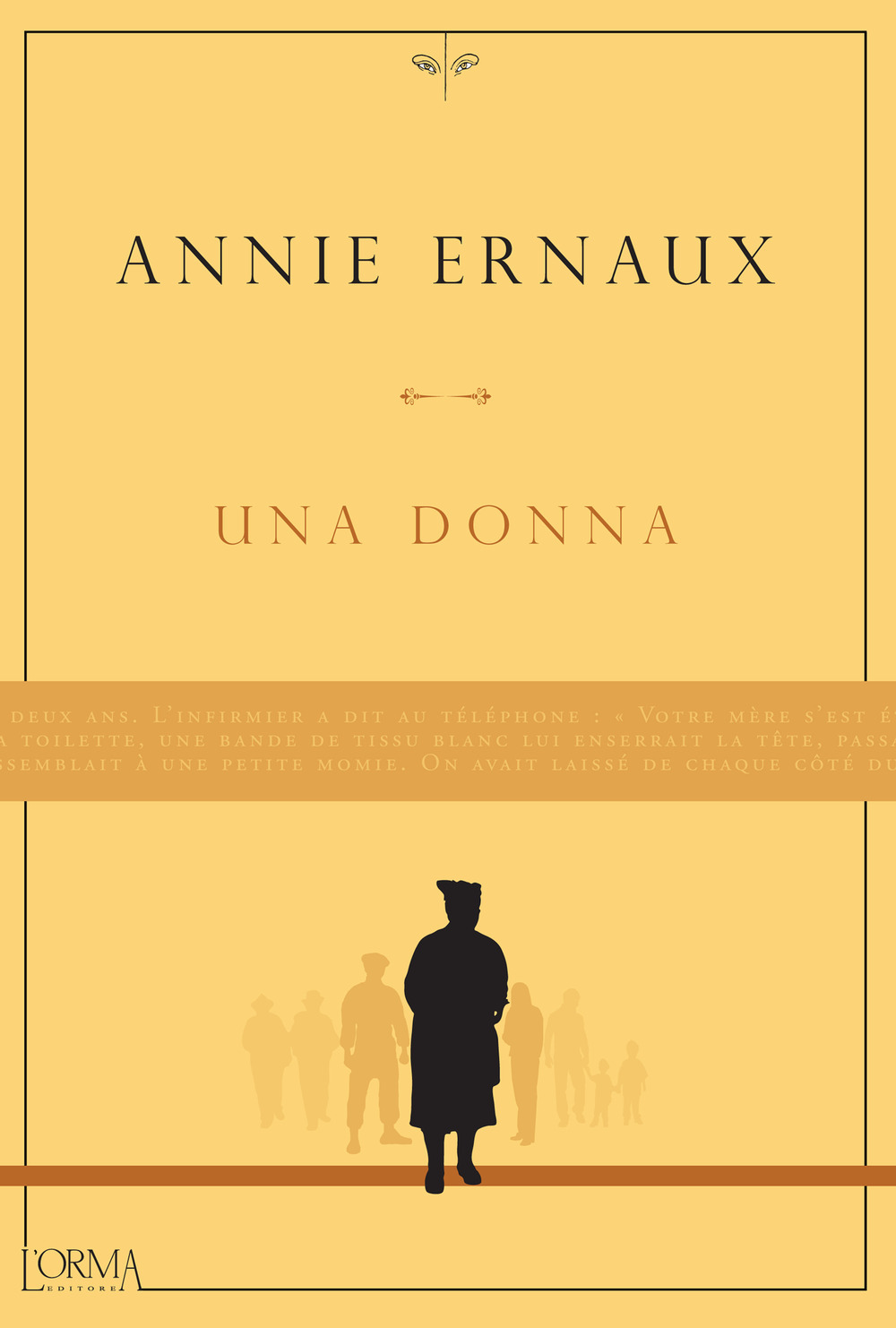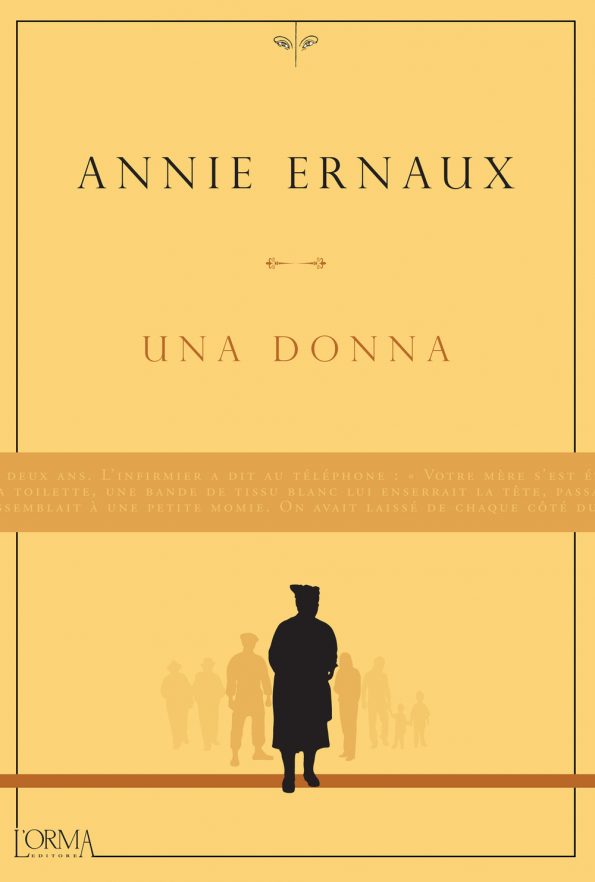Esce “Una donna” di Annie Ernaux (traduzione di Lorenzo Flabbi, editore L’Orma). E la morte ci riunisce.
Molti pensano che il più grande tabù della nostra epoca sia rappresentato dal sesso ma è un errore, figlio di un clamore percepito. Il più grande tabù è sicuramente la morte (il sesso è solo forse un semplice effetto collaterale dell’insondabilità ingombrante che la morte naturalmente possiede).
La scrittrice francese Annie Ernaux lo sa bene e in “Una donna” (che esce adesso nella traduzione di Lorenzo Flabbi – traduttore-editore de L’Orma a cui dobbiamo la riscoperta e consacrazione della scrittrice francese) racconta senza imbarazzi la fine della madre in un’autofiction spudorata e chirurgica nel racconto che è però, allo stesso tempo, poetico e mai freddo.
Un vicino-lontano che poi si traduce in un gesto di riconciliazione:
“Vorrei conservare di mia madre delle immagini puramente affettive il calore delle lacrime senza dar loro un senso.”
È il 7 aprile quando viene chiamata dalla casa di riposo in cui soggiorna la donna da una paio di anni per una demenza senile. Un giorno preciso, una telefonata e così inizia la frase che inaugura il foglio bianco su cui scrivere il resoconto della “donna del mio immaginario”. Ricordare e raccontare una vita in quello che è, a tutti gli effetti, un progetto letterario: su questo la Ernaux attrice-autrice del breve romanzo non cerca sotterfugi.
“Aprile è il più crudele dei mesi” scriveva Thomas Stearns Eliot in “La sepoltura dei morti” sezione di “La terra desolata”. Coincidenze. Ma la narratrice nel suo romanzo uscito in Francia nel 1987, non è né desolata, né ce l’ha con la crudeltà dell’inizio della primavera. Ha, piuttosto, il desiderio-bisogno di cogliere in questo corpo a corpo con il ricordo della madre “anche la donna che esistita al di fuori della donna reale”.
La madre, lo dice nella requisitoria impietosa ma versificata: “conosceva tutti gesti che addomesticano la miseria”. Nel rendicontare la genitrice il tempo si cristallizza nei ricordi e, prima di questi, nella rievocazione operata attraverso le foto dalla figlia che di tutto questo ripercorrere diventa la sola “archivista”.
È una donna semplice quella che scopriamo nella ripresa delle sue umili origini? Non diremmo. La complessità è nella passione della madre per il catechismo e la canzone religiosa che fanno il paio con l’attenzione al risparmio domestico ma le due prospettive apparentemente sommesse e a orizzonte vicino hanno il contraltare nella percezione della grandezza dell’universo e della possibilità di un riscatto economico-sociale negate al marito e padre della protagonista più concreto e perciò meno ambizioso. E non sembra casuale che queste strade che dividono la coppia generino persone diverse, esperienze diverse. È lei, la madre, che ottiene il riscatto aprendo un alimentari-bar non il marito a produrre sidro e coltivare l’orto alle spalle di questo.
La donna è restituita in tutta la sua sofferenza e nelle piccole debolezze, le minime ritorsioni: l’odio, ad esempio, per la margarina dopo aver lavorato per anni in una fabbrica che la produceva. Come pure un episodio curioso e triste che fa avvertire il prezzo dell’alienazione. La donna è a due passi dal capo reparto a cui è capitato un incidente imprevisto -la sciarpa gli si è infilata negli ingranaggi della macchina ed è lì e potrebbe ma non lo soccorre.
Minime rivalse su cui pende il pungolo del destino; anche solo di quello temuto.
“La giovinezza di mia madre è stata -scrive la Ernaux nel memoir- in parte questo: un tentativo di sfuggire al destino più probabile, di certo la miseria, forse l’alcol.”
Poi arrivano le nozze raccontate in una foto davanti a una cascina in campagna. L’acconciatura, la gonna corta, le aspettative: “Per una donna il matrimonio era la vita o la morte, la speranza di cavarsela meglio in due o il tracollo definitivo.”
Il padre è un uomo buono e un po’ più adulto di lei, sistemato: è la scelta giusta. Di lui la figlia dice: “Con lui mi divertivo, con lei avevo delle “conversazioni”. Dei due era lei la figura dominante, la legge.” La madre.
E la legge quando arriva l’età dell’adolescenza crea un’inevitabile dissidio tra le donne: che si attesta su una linea di separazione e di confine: fianchi e seno, i luoghi da nascondere per una e valorizzare per l’altra.
D’altronde la genitrice aveva ambizioni più socialmente accettabili dal punti di vista del mostrarsi: “fare l’elegante non sfigurare” e cancellare così l’onta dell’essere “di campagna”. Un riscatto sociale che si traduce in un protezionismo anche materno: “Il suo desiderio per profondo era darmi tutto ciò che non aveva avuto lei”. Ma lei, la figlia, non cerca il riscatto sociale. Anche nel matrimonio cerca di incontrare solo la passione, la condivisione non uno status sociale migliore – quello che invece coglie la madre ne legame e intima alla figlia di non farsi rimandare indietro come se la giovane sposa andasse a fare un lavoro, un’assunzione più che un’unione.
Per concludere, se vi state chiedendo perché uno dovrebbe scrivere di morte, perché uno dovrebbe ricordare i propri estinti anche fuori dalla narrativa la risposta è a pagina 96 quando la Ernaux scrive “Ora tutto è legato”. E il libro potrebbe finire qui, salvo poi il finto finale, la coda ulteriore. Legarci, legare la nostra storia. Perché solo così ci riuniamo a noi stessi, solo così il cerchio -anche se nel ricordo e basta- è compiuto. Ora possiamo dire di essere (e essere stati). Veramente.